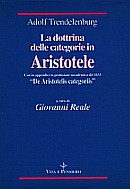 |
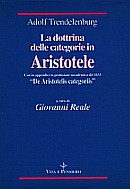 |
Il brano riproduce il primo paragrafo del saggio (pp. 287-292)
Friedrich Adolf Tredelenburg è stato il primo studioso a tematizzare in modo esplicito la possibilità che lo schema categoriale di Aristotele fosse il risultato di una deduzione sistematica condotta a partire da un principio ben definito. In particolare, la sua tesi per cui a far da guida nella costruzione di questo schema sarebbe stato, almeno in un primo momento, un filo conduttore grammaticale, ha costituito nel corso della seconda metà del XIX secolo un punto di riferimento imprescindibile, sebbene quasi sempre polemico, per tutti coloro che hanno rivendicato la presenza di un'impalcatura quanto meno organica nella dottrina delle categorie di Aristotele.
Il carattere di «novità» dell'impostazione ermeneutica di tutti questi studi (ossia, la messa a fuoco sul «filo conduttore» e sulla «deduzione») fu dovuto in larghissima parte proprio agli strumenti teoretici approntati da Kant, detrattore rispettoso ma deciso della tavola aristotelica delle categorie, nella Critica della Ragion pura: il Leitfaden in questione, infatti, costituirebbe l'equivalente della tavola kantiana dei giudizi; la Deduktion, dal canto suo, venne intesa meno nel senso trascendentale del quid iuris, della «giustificazione» e della «legittimità», che in quello logico-metafisico della «dimostrazione della derivazione dal fondamento, dall'origine».
Questo richiamo innanzitutto terminologico a Kant fu perciò, nel contempo, un andare contro Kant, secondo il quale Aristotele non aveva seguito nessun filo conduttore nell'elaborazione dello schema categoriale, ma aveva piuttosto ricavato quest'ultimo per semplice induzione e in assenza di un principio sistematico.
Sulla scorta di tali suggestioni kantiane, Trendelenburg ritenne di poter porre su nuove basi lo studio delle categorie aristoteliche partendo dal presupposto che «esse, in un sistema filosofico ben costruito come quello aristotelico, non possono non rendere manifeste le proprie relazioni e conseguenze». In altre parole, l'inventore della sillogistica - ovvero della logica formale -, il pensatore comprensivo e speculativo come nessun altro, colui al quale la maggior parte delle scienze filosofiche devono il loro carattere distintivo e il loro inizio, non poteva aver escogitato l'Entwurf der Kategorien, lo schema categoriale, senza un criterio coerente. Presupposto certo non «scientificamente» fondato ma tuttavia in larga misura legittimo, tale da convincere Trendelenburg che, nonostante la mancanza di indicazioni precise nel corpus aristotelico pervenutoci, la presa in considerazione del contesto generale del pensiero di Aristotele avrebbe permesso di rinvenire il principio della classificazione delle categorie.
È un fatto, però, che l'esito delle ricerche di Trendelenburg sia stato inequivocamente aporetico. Esso potrebbe riassumersi nel modo seguente: Aristotele sembra aver scoperto le categorie, in quanto predicati supremi, seguendo un filo conduttore grammaticale (un proteron pros hemas), cioè la scomposizione della proposizione, e precisamente l'analisi dell'espressione e della forma del giudizio; le categorie, però, hanno anche un significato «reale», ontologico, e perciò in diversi luoghi delle opere aristoteliche il fondamento generativo, ciò che è anteriore per natura (il proteron tei physei), è apparso come il vero punto di vista della classificazione; in conclusione, «alla questione, posta in termini aristotelici: in che misura questo "primo per noi" (proteron pros hemas) coincide con il "primo per natura" (proteron tei physei), ovvero in che senso se ne distingue?, non riceviamo alcuna risposta».
Secondo Trendelenburg, comunque, l'aporia in questione va ascritta non alla propria indagine critica, ma, in ultima analisi, allo stesso Aristotele. È infatti possibile ricostruire in parte il percorso teoretico che ha condotto Aristotele a formulare in modo coerente lo schema categoriale, e si può dunque considerare ingiusta l'accusa kantiana di rapsodismo, ma la dottrina delle categorie resterebbe comunque segnata da una originaria «indecisione» aristotelica tra filo conduttore grammaticale e filo conduttore ontologico.
La maggior parte degli studiosi successivi che, in sede filosofica, si sono occupati del medesimo problema hanno giudicato legittima l'istanza di fondo di Trendelenburg, rigettando però in sostanza la sua tesi sul punto di vista grammaticale come filosoficamente costitutivo.
Oggi sono pochi gli specialisti che parlano ancora seriamente della dottrina aristotelica delle categorie nei termini di una «rapsodia» o di un mero elenco di concetti inferiti per via induttiva. Nella gigantomakhia peri ton kategorion inauguratasi proprio con Trendelenburg, tuttavia, quella tesi, a parte qualche eccezione nel secolo scorso, è stata aspramente combattuta e, possiamo dire, definitivamente sconfitta, tanto che nella prima metà del nostro secolo di essa si era quasi persa ogni memoria.
Accanto agli altri due classici versanti critici (la tesi del filo conduttore logico e quella del filo conduttore ontologico), sono state avanzate anche di recente nuove interpretazioni sulla genesi delle categorie aristoteliche; si è parlato, per esempio, di origine logico-semantica, retorica e persino giuridica, ma nessuno ha più ripreso e rimesso in gioco il punto di vista di Trendelenburg. Almeno, lo ripetiamo, in sede filosofica.
Se negli studi filosofici sulla dottrina aristotelica delle categorie il filone grammaticale risalente a Trendelenburg sembra ormai essersi esaurito da tempo, esso è tuttavia risorto con rinnovato vigore, e in termini soprendentemente simili, in un ambito epistemico tipicamente novecentesco, la linguistica strutturale.
In un breve saggio del 1958 dal titolo Catégories de pensée et catégories de langue, il linguista e filologo É. Benveniste, pur senza conoscere l'opera dello studioso tedesco, ha di fatto riproposto la medesima tesi, conferendole peraltro un significato che, come vedremo, mette in questione non solo l'istanza epistemica di tutti gli studi critici sulla dottrina in questione, non soltanto la legittimità di una particolare sfera problematica filosofica (le categorie del pensiero), ma addirittura l'«autonomia» stessa della filosofia rispetto alla lingua parlata.
Questa tesi, d'altra parte, oltre ad essere enunciata da uno studioso autorevolissimo, ha trovato accoglienza favorevole anche tra personalità di grande spessore culturale e filosofico. E ciò, secondo noi, la rende degna della più alta considerazione.
Ora, il fine del presente lavoro non è tanto quello di riaffermare la priorità del punto di vista ontologico nella deduzione della tavola delle categorie di Aristotele. In questa prospettiva, riteniamo che le argomentazioni addotte da Reale già nel suo articolo del 1957 - riprodotto in questo volume come Saggio introduttivo - siano pienamente soddisfacenti.
A tal proposito, anzi, dobbiamo aggiungere che il pensiero dello Stagirita rimarrà in un certo qual modo sullo sfondo del nostro discorso, e solo sporadicamente si faranno riferimenti espliciti a luoghi delle opere aristoteliche. Tutto questo sembra suonare strano, se non addirittura in aperto contrasto con l'argomento in questione.In realtà, lo stesso Benveniste non fonda affatto la propria interpretazione delle kathgorivai su un'analisi anche parziale dell'ontologia aristotelica. Al riguardo, si può dire che il suo discorso sia interamente afilosofico, quando non espressamente antifilosofico, e ciò, come vedremo, non comporta in linea di principio l'inattendibilità dei suoi risultati ermeneutici. Insomma, è a priori legittimo discutere epistemicamente di aspetti dottrinali filosofici anche secondo ottiche che non siano filosofiche o storico-filosofiche.
L'autentico proposito della nostra trattazione è piuttosto quello di collocare una volta per tutte il problema del filo conduttore grammaticale nella sua giusta dimensione speculativa, e in questo senso ci dedicheremo prevalentemente ad un confronto diretto con le critiche «radicali» che proprio Benveniste, prendendo lo spunto dalle categorie aristoteliche, ha mosso al pensiero filosofico in generale.
Vincenzo Cicero
© Copyright 1994
Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1
Milano